“Picchì certi affari complicati un si ponno rislovere ca dimocrazia.” Totò Riina
Quando si parla di Democrazia
 È vero, la storia dell’umanità è intrinsecamente collegata alla sopravvivenza del singolo e della specie, lo è dalla notte dei tempi, quando l’umanità iniziava a caratterizzarsi dal più generale consesso delle specie animali. Ed ha generate conquiste ed involuzioni, cultura personale e di socializzazione, intelligenza personale e intelligenza di gruppo, interessi di singoli e di gruppi sociali, religione ed ateismo ed altri incalcolabili progressi, poi ha cercato definire e di dare senso alla democrazia.
È vero, la storia dell’umanità è intrinsecamente collegata alla sopravvivenza del singolo e della specie, lo è dalla notte dei tempi, quando l’umanità iniziava a caratterizzarsi dal più generale consesso delle specie animali. Ed ha generate conquiste ed involuzioni, cultura personale e di socializzazione, intelligenza personale e intelligenza di gruppo, interessi di singoli e di gruppi sociali, religione ed ateismo ed altri incalcolabili progressi, poi ha cercato definire e di dare senso alla democrazia.
Il termine demokratía comincia a circolare verso la fine del VI secolo avanti Cristo e sin da allora tende a definire le relazioni tra i cittadini di uno stato sovrano.
Così per alcuni demokratía indica il dominio coercitivo, esercitato con la forza, di quella parte del popolo che è il démos (storicamente con esclusione delle donne), mentre dall'altro esprime il sopravvento della componente quantitativamente, ma non qualitativamente, più significativa del popolo.
E così succede che nella democrazia di oggi, dove auspicata, e dove si pensa, siano incastonati tutti i valori positivi della persona, quando si tratta di declinare la democrazia nelle questioni “sociali “ si tratta spesso di darne un senso applicativo e di governarne i diritti e doveri (anche con la forza o con sanzioni), del singolo e della società attraverso emanazione di leggi ed ordinamenti, e dove occorra della loro interpretazione. Un percorso insidioso.
Lo stesso Totò Riina, noto e feroce capo mafia, arrivò a questa conclusione: "Perchè certi affari complessi non si possono risolvere con la democrazia."
Democrazia è anche consenso
-
Democrazia è anche consenso
Spesso al popolo o al singolo è necessario dirimere concetti derivanti da consuetudini o abitudini che rappresentano comportamenti non tradizionalmente concepibili con l’assunto di cultura democratica e dei valori che la compongo, come libertà, giustizia e così via, del singolo e della comunità.
Questo perché oggi alla parola democrazia (almeno nella sua origine etimologica) non si associa più la sola “forma stato”, o meglio non è quasi mai stata associata una forma stato, ma riguarda qualsiasi comunità di persone e delle decisioni che prende al suo interno. Così può accadere che possono essere tollerate se non giustificate a lungo nel tempo e da vasti gruppi di persone o da degli stati, dei modelli o dei valori non certo edificanti spesso violenti, repressivi o semplicemente inadeguati.
Buon voto a tutti
La nostra Repubblica Italiana si è dotata di una Costituzione dove sono presenti molte caratteristiche di democrazia formale ed alla quale si attengono le istituzioni ed i cittadini italiani. Quasi sempre.Sul voto l’articolo 48 cita: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico”.Detto questo da sempre e da parte di qualcuno è difeso il diritto all'astensione, sopratutto oggi quasi sempre davanti ad argomenti referendari “spinosi”.Ma non è così o almeno non dovrebbe esserlo. Primo perché l’astensione non è contemplata in nessun articolo della Costituzione, ne è contrapposta a nessun altro diritto o dovere.Anzi senza essere dei costituzionalisti o volersi sostituire alla Corte Costituzionale, l’articolo 48 sta nella prima parte della Costituzione (Titolo IV, rapporti politici), ha quindi un valore generale (da seguire ad ogni promulgazione di una legge), per i voti dati dagli elettori in qualsivoglia consultazione. Non è quindi collegato solo alla parte seconda (il Parlamento, elezione della Camera, articolo 56). Ma anche all’articolo 75 che afferma che “hanno diritto” a partecipare ai referendum i cittadini chiamati ad eleggere la Camera; in questo caso è si previsto il quorum della maggioranza, ma non si dice affatto che non votare è riconosciuto come un diritto costituzionale, pur essendo una scelta legittima.Quindi votare è “un dovere civico”. Cè da aggiungere che durante il dibattito alla Costituente (erano altri tempi, luglio 1946, e con altri statisti!), non passò – perché non si volle essere troppo esigenti e vincolanti – una versione del secondo comma dell’art. 48 che così diceva: il voto è “un dovere civico e morale”. Si pensò che, dato che si intendeva sanzionare nella legge elettorale gli elettori non votanti, non era opportuno censurare un atto che investiva una qualità morale del cittadino. Scrupoli costituzionali che oggi sarebbero davvero impensabili!
Cè da aggiungere che durante il dibattito alla Costituente (erano altri tempi, luglio 1946, e con altri statisti!), non passò – perché non si volle essere troppo esigenti e vincolanti – una versione del secondo comma dell’art. 48 che così diceva: il voto è “un dovere civico e morale”. Si pensò che, dato che si intendeva sanzionare nella legge elettorale gli elettori non votanti, non era opportuno censurare un atto che investiva una qualità morale del cittadino. Scrupoli costituzionali che oggi sarebbero davvero impensabili!Successivamente l’argomento fu ripreso e determinò una sentenza della Corte costituzionale (n.96, 2 luglio 1968):
nelle considerazioni in diritto, al punto 3, si legge che “in materia di elettorato attivo, l’articolo 48, secondo comma, della Costituzione ha, poi, carattere universale ed i princìpi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”.
E poi non dimentichiamo anche che fino all’abrogazione nel 1993 i cittadini non votanti per le elezioni delle Camere, venivano sanzionati (dpr n.361 del 30 marzo 1957). Le consultazioni referendarie erano ancora lontane. Articolo 4:
” L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese”.
Ma c’era ben di più all’articolo 115:
“L’elettore che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al sindaco (….) L’elenco di coloro che si astengono dal voto (…)senza giustificato motivo è esposto per la durata di un mese nell’albo comunale (…) Per il periodo di cinque anni la menzione ‘non ha votato’ è iscritta nei certificati di buona condotta (…)”.
A proposito appunto delle consultazioni referendarie ecco uno dei primi esempi passati in sordina di palese violazione della democrazia, i referendum abrogativi sulle norme per la procreazione assistita. Fu la vittoria dell’astensionismo su un argomento spinoso. Perché i referendum non raggiunsero il quorum minimo, solo il 25,9% degli aventi diritto si reca alle urne.
Due visioni contrapposte la prima all’interno del rispetto della democrazia ed una esterna a questo processo con evidenti caratteristiche di contrapposizione.Nel caso alcune alte cariche istituzionali del tempo affermarono pubblicamente:“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico”. Giorgio Napolitano più volte nella lunga carriera politica.“ Vado a votare, perché il referendum è una forma di partecipazione del cittadino. Può stare a casa, è un suo diritto, ma in questo modo si incentiva l’assenza di partecipazione. Puntare sul fallimento del quorum sarà anche legittimo, ma è politicamente sbagliato”. Fini da presidente della Camera.” Non mi recherò a votare. E’ un diritto dei cittadini decidere se votare o meno per il referendum”. Berlusconi premier all’epoca.“Non votare è un diritto costituzionale”. Sacconi ministro del Lavoro.“... frutto della maturità del popolo italiano, che si è rifiutato di pronunciarsi su quesiti tecnici e complessi, che ama la vita e diffida di una scienza che pretenda di manipolare la vita”. Camillo Ruini cardinale, arcivescovo italiano dopo una lunga campagna mossa sull'argomento dalla Chiesa romana.Certo astenersi è una facoltà ma si può anche deporre nell’urna una scheda bianca (se non ci si vuole esprimere nel merito), adempiendo così al dovere di votare. Se non altro si comporerebbe un disegno più coerente ed evidente delle scelte del "popolo sovrano".
Piove, Governo ladro
-
Nell'ottocento italiano e fino alla prima guerra mondiale la democrazia ebbe diverse interpretazioni e tentativi di applicazione.
Piove, Governo ladro!L’espressione viene da molto lontano, dall’anno della fondazione del regno d’Italia a coronamento del lungo periodo conosciuto come “Risorgimento”, quando apparve su giornale “il Pasquino” una vignetta di Casimiro Teja, che commentava il fallimento a seguito della pioggia, di una dimostrazione di mazziniani a Torino. Antonio Gramsci si ripeteva comunemente, in modo interlocutorio, con la frase “L'avevo detto io! Piove, governo ladro!”. Per satireggiare l’attitudine diffusa di dare polemicamente, la colpa di ogni cosa al governo. Più recentemente i giovani rivoluzionari del sessantotto, ne fecero una una curiosa estensione figurata, manifestando davanti alla prefettura “Fuori piove dentro si sta bene”. Sembrerebbe che a Torino ci sia un meteo piuttosto sfavorevole alle azioni politiche.
Antonio Gramsci si ripeteva comunemente, in modo interlocutorio, con la frase “L'avevo detto io! Piove, governo ladro!”. Per satireggiare l’attitudine diffusa di dare polemicamente, la colpa di ogni cosa al governo. Più recentemente i giovani rivoluzionari del sessantotto, ne fecero una una curiosa estensione figurata, manifestando davanti alla prefettura “Fuori piove dentro si sta bene”. Sembrerebbe che a Torino ci sia un meteo piuttosto sfavorevole alle azioni politiche.Daltra parte Gramsci affronta e approfondisce l'argomento quando scrive sui Quaderni il lungo paragrafo: Passato e presente. Centralismo organico e centralismo democratico. Disciplina
Come deve essere intesa la disciplina, se si intende con questa parola un rapporto continuato e permanente tra governanti e governati che realizza una volontà collettiva? Non certo come passivo e supino accoglimento di ordini, come meccanica esecuzione di una consegna (ciò che però sarà pure necessario in determinate occasioni, come per esempio nel mezzo di un’azione già decisa e iniziata) ma come una consapevole e lucida assimilazione della direttiva da realizzare. La disciplina pertanto non annulla la personalità in senso organico, ma solo limita l’arbitrio e l’impulsività irresponsabile, per non parlare della fatua vanità di emergere. Se si pensa, anche il concetto di «predestinazione» proprio di alcune correnti del cristianesimo non annulla il così detto «libero arbitrio» nel concetto cattolico, poiché l’individuo accetta «volente» il volere divino (così pone la quistione il Manzoni nella Pentecoste) al quale, è vero, non potrebbe contrastare, ma a cui collabora o meno con tutte le sue forze morali. La disciplina pertanto non annulla la personalità e la libertà: la quistione della «personalità e libertà» si pone non per il fatto della disciplina, ma per l’«origine del potere che ordina la disciplina». Se questa origine è «democratica», se cioè l’autorità è una funzione tecnica specializzata e non un «arbitrio» o una imposizione estrinseca o esteriore, la disciplina è un elemento necessario di ordine democratico, di libertà. Funzione tecnica specializzata sarà da dire quando l’autorità si esercita in un gruppo omogeneo socialmente (o nazionalmente); quando si esercita da un gruppo su un altro gruppo, la disciplina sarà autonoma e libera per il primo, ma non per il secondo.
In caso di azione iniziata o anche già decisa (senza che ci sia il tempo di rimettere utilmente in discussione la decisione) la disciplina può anche apparire estrinseca e autoritaria. Ma altri elementi allora la giustificano. È osservazione di senso comune che una decisione [(indirizzo)] parzialmente sbagliata può produrre meno danno di una disubbidienza anche giustificata con ragioni generali, poiché ai danni parziali dell’indirizzo parzialmente sbagliato si cumulano gli altri danni della disubbidienza e del duplicarsi degli indirizzi (ciò si è verificato spesso nelle guerre, quando dei generali non hanno ubbidito a ordini parzialmente erronei e pericolosi, provocando catastrofi peggiori e spesso insanabili).
Italia e tracce di democrazia
-
Parlando dell’Italia (stato sovrano) e di forme di democrazia
Intanto dobbiamo dire che fino al 2 giugno 1946 l’Italia era una monarchia, del tutto simile a quella di molti stati d’Europa.
Nelle scuole italiane si insegna che le origini dello Stato italiano risalgono intorno all'anno mille, quando fu creata la "Contea di Savoia" elevata nel 1416 a "Ducato di Savoia". Dal 1713 al 1720 il Ducato cambiò denominazione in "Regno di Sicilia" poichè i Savoia avevano ottenuto il titolo regio con l'annessione al preesistente Regno di Sicilia. Il Regno di Sicilia fu poi restituito dai Savoia agli Asburgo in cambio del preesistente Regno di Sardegna, così dal 1720 il Ducato divenne "Regno di Sardegna" finchè il 17 marzo 1861, il XXIV re di Sardegna, Vittorio Emanuele II di Savoia, proclamò la nascita del "Regno d'Italia".
Sebbene il Regno d'Italia ereditasse le leggi e la soggettività giuridica dello Stato piemontese, la realizzazione dell'unificazione nazionale fece dello Stato italiano una entità politica del tutto nuova frutto del Risorgimento italiano: dai moti carbonari alle rivolte mazziniane, dalla "primavera dei popoli" alla prima e seconda guerra d'indipendenza, alla spedizione dei Mille di Garibaldi.
Lo Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848, noto come Statuto Albertino, dal nome del re che lo promulgò, fu lo statuto costituzionale adottato dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848 a Torino. Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d'Italia, divenne la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1º gennaio 1948.
La natura flessibile dello Statuto Albertino potè garantire, sino agli anni 1920/21, un'evoluzione parlamentare del sistema politico senza rendere necessarie modifiche effettive al testo originale: gradualmente i Governi cessarono di dipendere dalla fiducia del Re, mentre divenne necessaria quella del Parlamento. Anche il Senato perse importanza di fronte alla Camera dei deputati, il Re tuttavia mantenne una particolare influenza sulla politica estera e su quella militare: basti pensare che la tradizione voleva che i ministri della Guerra e della Marina (provenienti dai ranghi militari) fossero designati dal Re al Presidente del Consiglio dei ministri.
 L'evoluzione parlamentarista dello Statuto cessò completamente con l'avvento della dittatura fascista.
L'evoluzione parlamentarista dello Statuto cessò completamente con l'avvento della dittatura fascista.Diritti e doveri dei “regnicoli”
 Lo statuto data l’epoca storica trattava alcuni innovativi principi.
Lo statuto data l’epoca storica trattava alcuni innovativi principi.Riconosce il principio di eguaglianza art. 24: «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge [...]. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi»).
Riconosce formalmente la libertà individuale (art. 26), l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), la libertà di riunione (art. 32).La religione "è quella Cattolica, Apostolica e Romana" (art. 1). Poco dopo verrà l'emancipazione prima dei Valdesi (17 febbraio- Lettere Patenti) e poi degli Ebrei (29 marzo) con il riconoscimento dei loro diritti civili e politici, infine con l'abolizione dei “privilegi” ecclesiastici a partire dal 2 marzo successivo con un decreto regio che cacciava i Gesuiti dallo Stato.Una legge di poco posteriore (Legge Sineo del giugno del 1848) aggiungeva che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari.
Alcune regioni hanno origini e storie differenti
Fu anche un processo di annessioni territoriali, che continuò anche dopo la proclamazione del regno d’Italia con le guerre del 1866 e 1870, e del 1915-18 e che continuò fino alla seconda guerra mondiale, quando finita la guerra furono effettuate le ultime modifiche che hanno determinato gli attuali confini territoriali dello Stato italiano.
Le democrazia è cristiana
-
La democrazia è cristiana
 Il 2 Giugno 1946, contemporaneamente alla consultazione popolare per eleggere i membri dell'Assemblea costituente, fu indetto un referendum per scegliere fra monarchia e repubblica. Risultarono favorevoli alla Repubblica 12.717.923 elettori, mentre 10.719.284 furono i voti favorevoli alla monarchia e 1.498.136 i voti nulli. L'assemblea costituente risultò composta da 207 deputati della Democrazia Cristiana, 115 socialisti, 104 comunisti su un totale di 556 deputati.Di lì a poco avvenne uno strappo cruciale per il futuro dell’Italia “democratica”. Siamo al tempo del IV governo De Gasperi (31 maggio 1947- 23 maggio 1948) quando si consumò un avvenimento politico decisivo:
Il 2 Giugno 1946, contemporaneamente alla consultazione popolare per eleggere i membri dell'Assemblea costituente, fu indetto un referendum per scegliere fra monarchia e repubblica. Risultarono favorevoli alla Repubblica 12.717.923 elettori, mentre 10.719.284 furono i voti favorevoli alla monarchia e 1.498.136 i voti nulli. L'assemblea costituente risultò composta da 207 deputati della Democrazia Cristiana, 115 socialisti, 104 comunisti su un totale di 556 deputati.Di lì a poco avvenne uno strappo cruciale per il futuro dell’Italia “democratica”. Siamo al tempo del IV governo De Gasperi (31 maggio 1947- 23 maggio 1948) quando si consumò un avvenimento politico decisivo:l'esclusione dal governo dei partiti di sinistra (socialisti e comunisti) quindi il passaggio da una situazione di collaborazione fra tutti i partiti antifascisti a una situazione di forte contrapposizione tra i partiti di governo (Democrazia Cristiana e suoi alleati) e i partiti di opposizione (costituiti a sinistra dal partito comunista e a destra dal Movimento Sociale Italiano formatosi nel '47 come erede ideale del fascismo).
Fu un mutamento determinante per lo sviluppo della democrazia italiana, causato da molti fattori ma i due più importanti sono stati:
- la situazione internazionale che si era determinata con lo scoppio della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica e rispettivi alleati;
- la scissione del Partito Socialista Italiano, detta scissione di palazzo Barberini, che determinò la nascita del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (in seguito Partito Socialista Democratico Italiano), nel quale confluì quasi la metà dei parlamentari socialisti eletti nell'Assemblea costituente appartenenti alla corrente socialdemocratica guidata da Giuseppe Saragat, il quale rimproverava al Partito Socialista Italiano legami troppo stretti con l'Unione Sovietica e un sostanziale appiattimento sulle posizioni del Partito Comunista Italiano, a differenza di quanto accadeva nel resto d'Europa dove i partiti socialisti avevano assunto posizioni autonome.
La conseguenza fu la cristallizzazione dei ruoli di alcuni partiti politici, destinati a restare o permanentemente al governo o permanentemente all'opposizione, bloccando qualsiasi ipotesi di alternanza politica e determinando una anomalia nella forma di governo parlamentare italiana.
Democrazia e retorica
-
Democrazia e retorica
La Costituzione della Repubblica italiana si compone di due parti: la prima enuncia una serie di principi costituzionali cui l'ordinamento giuridico deve uniformarsi, la seconda riguarda l'organizzazione costituzionale dello Stato e disciplina il ruolo e le funzioni del Parlamento, del Governo e del Capo dello Stato.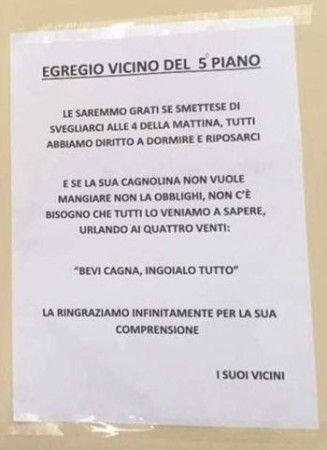 La democrazia si ottiene anche e sopratutto quando apparentemente piccoli tasselli del pensiero e dell’intelligenza umana raggiungono o si aggiungo in modo coerente ad una coscienza ed a una volontà diffusa e consapevole. Questo succede quando si esauriscono ed approdano alla legge le interpretazioni tra diritto e dovere dei singoli in aderenza ad un bene sociale diffuso e si giunge ad una applicazione diffusa e consapevole.Ma non ci si può esimere dal conoscere e condividere gli strumenti che strutturano questo percorso.Come ad esempio la retorica ed il suo utilizzo, sia nell'ambito del diritto e quindi nell’esperienza giudiziaria, che nel confronto politico e giudiziario.Guardando ai primi esempi del passato nell'Atene democratica l’assemblea e il tribunale esprimono istituzionalmente il volere del dêmos: “Il popolo si è reso padrone assoluto di tutto, e governa ogni cosa con decreti dell’assemblea e con i tribunali, nei quali il popolo è sovrano” (Aristot. Ap 41, 2).E questo avviene in entrambi i contesti, politico e giudiziario, differenziati sul piano delle procedure ma comunque caratterizzati da alcune significative affinità come: iniziativa del singolo; necessità di sostenere un dibattito sottoposto a votazione di fronte ad un uditorio di cittadini comuni che rappresenta il dêmos nella sua totalità; inappellabilità della decisione, la capacità di chi si rivolge al dêmos di convincerlo della validità della propria posizione politica (in assemblea) o della correttezza giuridica del proprio comportamento (in tribunale) sembra fondamentale.Ed anche il verdetto del tribunale, reso a maggioranza e senza preventiva discussione da parte di giudici mancanti di specifica competenza legale e privi dell’assistenza di un giudice togato, appare in prima istanza esito della persuasione dell’uditorio operata da una delle parti in causa: pur non mancando affatto nel processo l’esigenza dell’accertamento del fatto. È l'efficacia della narrazione e capacità argomentativa dell’oratore che svolgono un ruolo essenziale nella conclusione favorevole di un procedimento giudiziario.
La democrazia si ottiene anche e sopratutto quando apparentemente piccoli tasselli del pensiero e dell’intelligenza umana raggiungono o si aggiungo in modo coerente ad una coscienza ed a una volontà diffusa e consapevole. Questo succede quando si esauriscono ed approdano alla legge le interpretazioni tra diritto e dovere dei singoli in aderenza ad un bene sociale diffuso e si giunge ad una applicazione diffusa e consapevole.Ma non ci si può esimere dal conoscere e condividere gli strumenti che strutturano questo percorso.Come ad esempio la retorica ed il suo utilizzo, sia nell'ambito del diritto e quindi nell’esperienza giudiziaria, che nel confronto politico e giudiziario.Guardando ai primi esempi del passato nell'Atene democratica l’assemblea e il tribunale esprimono istituzionalmente il volere del dêmos: “Il popolo si è reso padrone assoluto di tutto, e governa ogni cosa con decreti dell’assemblea e con i tribunali, nei quali il popolo è sovrano” (Aristot. Ap 41, 2).E questo avviene in entrambi i contesti, politico e giudiziario, differenziati sul piano delle procedure ma comunque caratterizzati da alcune significative affinità come: iniziativa del singolo; necessità di sostenere un dibattito sottoposto a votazione di fronte ad un uditorio di cittadini comuni che rappresenta il dêmos nella sua totalità; inappellabilità della decisione, la capacità di chi si rivolge al dêmos di convincerlo della validità della propria posizione politica (in assemblea) o della correttezza giuridica del proprio comportamento (in tribunale) sembra fondamentale.Ed anche il verdetto del tribunale, reso a maggioranza e senza preventiva discussione da parte di giudici mancanti di specifica competenza legale e privi dell’assistenza di un giudice togato, appare in prima istanza esito della persuasione dell’uditorio operata da una delle parti in causa: pur non mancando affatto nel processo l’esigenza dell’accertamento del fatto. È l'efficacia della narrazione e capacità argomentativa dell’oratore che svolgono un ruolo essenziale nella conclusione favorevole di un procedimento giudiziario.Vediamo allora degli esempi di comparazione sui “germi di democrazia” più contemporanei.
Democrazia e ordinamento della chiesa Cattolica
-
La democrazia dello stato e l’ordinamento della chiesa Cattolica
Non c’è dubbio sul fatto che la chiesa cattolica più di altre religioni abbia a confrontarsi con istanze democratiche resilienti e presenti in molti diversi stati e ordinamenti costituzionali diversi.
Ad esempio guardando all’Italia e alla Germania si notano immediatamente molte posizioni in contraddizione che alimentano il discorso sulla democrazia.
Un esempio "leggero" ultimamente in auge: Sì/No alle donne prete?
I vescovi tedeschi, non proprio tutti ma sempre di più, chiedono che le donne possano essere ordinate prete. Perché no? Gesù non l'ha mai vietato.I suoi apostoli erano tutti uomini, ma le figure più importanti nei Vangeli sono donne.E chiedono anche che venga messa fine al celibato per i preti. In Italia la Chiesa romana , è da sempre la principale “guida” religiosa del paese.La Repubblica Italiana in modo laico riconosce lo stato di diritto a molte altre confessioni religiose.Tra queste c’è anche la Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo nata negli Usa a metà del 1990, a iniziativa, «di sacerdoti e laici della Chiesa cattolica romana e altri riti cattolici alla ricerca di riforme e rinnovamento nelle Chiese, cercando il dialogo ecumenico attivo, promuovendo l’unità fra le Chiese cristiane».Dal Vaticano nessun riconoscimento ufficiale ma padre Karl il teologo fondatore, ha scritto qualche anno fa una corposa lettera al Papa e frequenta il Vaticano.Mons. Agostino De Caro, sacerdote “ecumenico” in Licata, è stato nel 2018 nominato arcivescovo, consentendo l’elevazione della Comunità agrigentina ad Arcidiocesi Metropolitana della Diocesi d’Italia della Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo.
È nel 2019 che a Catania, seguendo alla lettera i riti di Santa Romana Chiesa per l’ordinazione presbiteriale, è consacrata la prima donna sacerdote in Italia, Raffaela Luciana Possidente, ora Madre Raffaela.
Accanto a Raffaela, per tutto il tempo, l’emozionatissimo marito Alessandro, titolare di un’impresa di ristrutturazione edile, che ha retto la casula e la stola che la moglie ha poi vestito al termine del rito: un’inclusione non per caso visto che, come ha detto l’officiante, «la vocazione di un presbitero sposato non può essere che condivisione con il coniuge e la famiglia. E questo vale, ovviamente, sia per l’uomo che per la donna». Accanto anche due dei tre figli, i suoceri, i parenti, i confratelli della stessa fede venuti da ogni parte di Sicilia e i fedeli che da tempo seguono Raffaela nella cappella privata, ricavata da un garage nelle vicinanze di casa, sulla collina di Vampolieri, intitolata a Santa Gemma Galgani. E a chiusura il messaggio che Madre Raffaela, tiene a veicolare attraverso la sua vicenda.
«Donne che come me avete la vocazione di diventare sacerdotesse, fatevi avanti, abbiate coraggio: nella nostra Chiesa c’è spazio anche per voi. Non vi preoccupate delle prime reazioni degli altri rispetto a questa scelta: anche mio marito all’inizio non capiva il senso di una donna prete, ma poi mi ha accompagnata in questa scelta. Ecco, vorrei trasmettere coraggio».
In Germania è del tutto normale che le donne siano Pastor nella Chiesa di Lutero. I pastori hanno moglie, oppure un compagno che presentano alla comunità, o anche le pastore vivono con una compagna. Perché la Chiesa cattolica rimane attaccata al passato?
Sembra ovvio ma non è così ovvio, anzi. Ci sono esperienze di lunghi tratti di vita che non sono sempre molto gratificanti.
Racconta una tedesca, figlia di un pastore, che ha sposato un pastore, da cui poi ha divorziato. Le signore della parrocchia che incontrava per strada, cambiavano marciapiede: «Mi chiamavano die Hexe», la strega. Vuole scrivere un libro sulle esperienze sue e delle tre sorelle. Avrà titolo Die Tochter des Pastors küss man nicht, “non si bacia la figlia del pastore”.Quando a scuola i compagni scoprivano chi era suo padre, si tiravano indietro.Il partner di un pastore ha un ruolo importante nella sua chiesa, svolge diverse mansioni, e dunque non potrebbe essere cattolico, anche se le norme variano da regione a regione.Il pastore è scelto dalla comunità, come dire assunto, e può venire licenziato. È normale che un pastore presenti il proprio partner, o compagno, e nel caso faccia outing. Quasi sempre i fedeli non hanno nulla in contrario.In Germania si cominciò a parlare della possibilità che le donne potessero diventare pastore dopo la Grande Guerra. Molti pastori erano caduti al fronte, e in certe regioni la proporzione era di un pastore per diecimila fedeli. Due donne vennero ordinate nel '43, durante l'ultima guerra, ma fu un'eccezione, Si dovette attendere il primo ottobre del 1958 per ammettere ufficialmente le donne.E gli inizi non furono facili, molti fedeli opponevano resistenza, e i pastori avevano diritto di veto contro una donna al suo fianco come Vikarin, vicaria.Le pastore erano obbligate al celibato, nonostante che l'Arbeitsgericht, il Tribunale del lavoro, avesse dichiarato questa clausola illegale in tutte le attività.Ma la Chiesa di Lutero si considerava ancora al di sopra della legge dello stato.Una pastora moglie e madre, si riteneva, non avrebbe avuto tempo per i propri parrocchiani. Ancora negli Anni Sessanta le pastore volontariamente evitavano di sposarsi, oppure si dimettevano.Il vescovo di Amburgo, Karl Witte, nel 1967 disse: «Le donne pastore non possono essere paterne, ma noi preghiamo Vater Gott, Dio padre».La resistenza alle donne pastore era più o meno forte da regione a regione, e l'ultima ad arrendersi fu la cattolica Baviera, nel 1975.Nel 1992 Maria Jepsen divenne la prima donna vescovo al mondo, ad Amburgo. Nel 1999, Margot Käßmann divenne a 41 anni vescovo a Hannover, e dieci anni dopo presidente della Chiesa luterana in Germania. Come dire la Papessa, ma è una forzatura, che irrita giustamente i protestanti.Il presidente è eletto dai vescovi, e la carica è a tempo. Quando divenne Papa (chiaramente una forzatura ma rende l'idea), era divorziata da due anni e aveva quattro figlie. Rimase in carica un anno. Il 20 febbraio del 2010, alle 23, fu sorpresa al volante ad Hannover, con un tasso di alcol di 1,54, il triplo del consentito.La comunità la perdonò, e anche i vescovi, capita a tutti, ma lei si dimise: «Non posso predicare bene, e comportarmi male».I luterani non conoscono il perdono, che solo Dio può concedere, e non si perdonano. Peccato. Nel giugno del 2018 è andata in pensione.Oggi, quasi un terzo delle parrocchie protestanti in Germania ha una pastora. E diventano sempre più numerose. Sfumature di democrazia
-
Sfumature di democraziaL'Italia, continuiamo coattivamente a ripeterlo, è uno stato a governo democratico, parrebbe quindi ovvio che hai banchi del parlamento siedano i rappresentanti del popolo intenti a legiferare sulla democrazia e le sue forme, ed è così, ma ovviamente in varie sfumature di democrazia. Ad esempio:
Omofobia (legge sulla... del 2022)
C’era in Italia una opportunità di inserire un nuovo germe di democrazia ed è diventata una opportunità mancata, come si può allora riprendere un percorso verso una maggior tutela democratica delle vittime e dei carnefici?
Si perché l’omofobia è un carattere dell’umanità che comprende atti di violenza estrema più o meno consapevole perpetuata da carnefici verso vittime più o meno consapevoli ma che ne trarranno danni fisici e morali, anche alimentati da componenti di accettazione passiva da parte di larghi strati “protetti” e più o meno consapevoli.
La storia degli iter parlamentari è nota. L’approdo definitivo di un percorso di legge è segnato dalla condivisione nei vari rami del parlamento e procede attraverso le insidie stesse presenti nel concetto di cultura democratica, dalle sue leggi e delle varie interpretazioni e liceità che ne conseguono.Si rimane costernati per le conseguenze prodotte da un semplice cavillo, interno all’ordinamento giuridico del senato, che ha consentito la negazione, la morte, ad un percorso di civiltà durato anni; limato in lunghe discussioni nelle commissioni parlamentari, passato al vaglio della Corte Costituzionale ed alla votazione alla Camera ed in attesa del giudizio del Senato.Ma questa è la Democrazia. Il DdL Zan (dal nome del primo firmatario) è stato ucciso. Come? Da una “tagliola” prevista dall’ordinamento giuridico che consente al Senato (eletto democraticamente) ed ai suoi componenti (che rivendicano il loro ruolo di sinceri democratici) di evitare la discussione di una legge. Lo hanno fatto, votando per impedire la discussione finale. quell’ultimo passaggio che avrebbe portato all’approdo un cammino di civiltà che aveva fino ad allora superato tutti gli ostacoli.Grazie soprattutto al voto segreto, che ha permesso di esprimere il dissenso a singoli parlamentari appartenenti a gruppi che si erano espressi per favorevoli, ed alla palese assenza di parlamentari di gruppi, che si erano fino a quel momento dichiarati favorevoli.Ddl Zan rivediamone didascalicamente la storia.
Origine
Il ddl Zan si riallaccia alla Legge Mancino del 1993, che sanziona incitamento all’odio, violenza e discriminazioni per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, tralasciando però comportamenti analoghi causati da omotransfobia e misoginia.
La nuova legge
Vorrebbe estendere le tutele, modificando gli aspetti sanzionatori previsti dall’articolo 604-bis del codice penale per chi “istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, aggiungendo “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Per quest’ultimi reati una modifica all’articolo 604 ter prevederebbe la circostanza aggravante.
Tra gli obiettivi della legge c’è inoltre l’istituzione della «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», da celebrare il 17 maggio.Il titolo completo del ddl Zan è ”Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”E mira ad ampliare le tutele in favore di coloro che sono più soggetti ad episodi di violenza e discriminazione: omosessuali, transessuali, donne e disabili. Prende il nome dal relatore, ovvero il deputato del Pd Alessandro Zan, attivista Lgbt noto soprattutto per aver promosso ed ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche a quelle omosessuali.Nel Ddl troviamo dieci articoli di cui il primo fa chiarezza e definisce i termini di “sesso”, “genere”, “orientamento sessuale” e “identità di genere”.Il secondo modifica l’articolo 604-bis del codice penale e il terzo articolo ne precisa l’aggravante.L’art. 4 (“Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”), la cosiddetta clausola di salvaguardia, garantisce la libera espressione di convincimenti od opinioni.L'articolo 5 allinea il ddl Zan alle altre norme di legge alla stessa fattispecie, come la Legge Mancino.L'art. 6 modifica l'articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, mentre l'articolo 7 istituisce la Giornata nazionale contro l’omotransfobia.L’iter legislativo e l’arma fumante al senato
Con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, il ddl Zan viene approvato il 4 novembre 2020 dalla Camera dei Deputati. Poi rimane bloccato in Commissione Giustizia al Senato: il relatore, Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione, è fortemente contrario alla proposta.
Dopo mesi di temporeggiamenti il ddl approda in Aula al Senato, ma qui lo attende la bocciatura definitiva. La Lega e Fratelli d'Italia propongono di ricorrere alla cosiddetta "ghigliottina o tagliola politica", una procedura speciale che fa riferimento in particolare all'articolo 96 del Regolamento del Senato. Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017. Di due articoli:
1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, un Senatore per ciascun Gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.2. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.La proposta è accolta e il Senato, a scrutinio segreto, ha votato a favore di quella che da allora sarà definita “tagliola”: ossia è stato bocciato l’esame del testo. A favore, 154 senatori, 131 i contrari e due astenuti. Presenti 288 senatori su 321 totali.
Gruppo parlamentare
Seggi
Movimento 5 Stelle
74
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione
64
Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC
50
Misto
48
Partito Democratico
39
Fratelli d'Italia
21
Italia Viva-P.S.I.
15
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)
8
I senatori assenti al momento del voto sono stati 32, rispetto al totale di 288 presenti. Di questi ultimi, un senatore non ha partecipato al voto, pur essendo fisicamente in aula.
Riguardo alle assenze, il gruppo più numeroso risulta il Misto a quota 16, rispetto al numero complessivo di 49 senatori, cioè la metà di tutte le assenze. In più mancavano 4 parlamentari del M5s sul totale di 74, 2 della Lega su 64, 3 di Forza Italia su 50 in tutto, 2 del Pd su 38, 4 di Italia Viva sul totale di 16 e uno del gruppo delle Autonomie. Unico gruppo presente al completo è quello di Fratelli d'Italia con 21 senatori.Difficile anche pensare che davvero tutta Italia Viva si sia defilata in blocco.Ma il dato è un altro: se anche il partito di Matteo Renzi (nel frattempo su un volo per l’Arabia) fosse stato compatto nel votare contro la tagliola, si sarebbe arrivati a circa 140 voti, non ai 149 previsti dal centrosinistra. E allora è successo qualcosa di diverso. Forse Italia viva ci ha messo del suo, ma probabilmente ci sono stati anche dei franchi tiratori nel Partito Democratico e nel Movimento 5 Stelle.Fra i pentastellati infatti ci sono alcuni senatori convinti: "Ma si sapeva che qualcuno di noi avrebbe fatto di tutto per non far passare il Ddl Zan".Insomma, intorno alla legge Zan, sembra essersi compattato quello che La Russa ha definito "nuovo centrodestra". Non c'è più la maggioranza di centrosinistra. Forse il segretario del Pd Letta pensava di averla in pugno e invece, quando si tratta di segnare il punto della vittoria, sbaglia a porta vuota.
Non è bastato neppure il voto in dissenso di Barbara Masini, la senatrice di Forza Italia che a luglio aveva fatto coming out, raccontando nell’Aula del Senato di avere una compagna: "Io sono una persona che appartiene alla comunità Lgbt. Ho messo la mia storia in piazza, l’ho fatto in un momento non semplice, ma sentivo la necessità di dare questo contributo e speravo che una parte politica, con coraggio, mettesse mano ad alcune posizioni e fosse più conciliante".Parla del Pd che non ha voluto mediare. "Io ho votato in dissenso, ma non sono delusa dal mio gruppo perché non ho mai ricevuto imposizioni. Io non sono un franco tiratore perché ci metto la faccia, con coerenza verso la mia parte politica. Ho sempre detto cosa avrei fatto, l’ho comunicato e mi sono confrontata. Ne avrei eventualmente pagato le conseguenze ove vi fossero state, ma la mia presidente Anna Maria Bernini è persona capace di comprensione e profonda intelligenza".Ma il voto di oggi non ha lasciato il partito di Berlusconi senza crepe.Il deputato di Forza Italia, Elio Vito ha pubblicato su Twitter la sua lettera di dimissioni al presidente Berlusconi da responsabile del dipartimento Difesa e Sicurezza di Forza Italia, "dopo che è stato annunciato al Senato il nostro voto favorevole al non passaggio agli articoli del ddl Zan. Su un tema che riguarda direttamente anche la sicurezza, Forza Italia ha manifestato, anche nei pochi voti che si sono sin qui stati al Senato, la sua contrarietà. Mi riferisco al ddl Zan, che contrasta proprio odio, discriminazioni e violenze", scrive Vito nella missiva. "Per coerenza quindi con le mie convinzioni, che mi portarono a votare a favore della proposta di legge alla Camera, quando pur nella posizione contraria del gruppo, fu garantita comunque la possibilità di votare secondo coscienza, a malincuore rimetto l'incarico che mi hai affidato", conclude rivolgendosi al leader azzurro Silvio Berlusconi.Qualcuno ci prova a far prevalere la forza all’amarezza, annunciando di non voler mollare. "Noi la presenteremo di nuovo" ha detto Faraone, ma intanto l'Italia dovrà aspettare ancora per una norma che punisca l'odio contro i gay. Il Ddl Zan è finito, almeno per questa legislatura.
 Ostellari e SalviniLo conferma anche la pentastellata Maiorino quando, a domanda, risponde che "pensare di ricominciare una battaglia del genere, praticamente daccapo, in Commissione Giustizia, dove permane il Presidente Andrea Ostellari (Lega) come dominus assoluto è impossibile”.
Ostellari e SalviniLo conferma anche la pentastellata Maiorino quando, a domanda, risponde che "pensare di ricominciare una battaglia del genere, praticamente daccapo, in Commissione Giustizia, dove permane il Presidente Andrea Ostellari (Lega) come dominus assoluto è impossibile”.I punti controversi della proposta di Legge
L’equivoco sull’identità di genere
Il disegno di legge definisce l’identità di genere come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Ma la Lega, così come tutto il centrodestra, è contraria al concetto di identità di genere.
Il tema della libertà d’espressione
Nonostante il contenuto dell’art. 4, secondo i suoi detrattori il ddl Zan sarebbe inoltre un bavaglio per le opinioni personali. Ma la legge non ostacolerebbe la libertà di espressione: la punibilità scatterebbe solo in caso di concreto pericolo di azioni discriminatorie o violente. Ad esempio, la propaganda contro la comunità Lgbt+ non sarebbe punibile.
I due punti contestati dalla Chiesa
Nel dibattito è entrata anche la Chiesa: per il Vaticano, il ddl Zan violerebbe il Concordato, cioè il documento che regola il rapporto fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, aggiornato per l’ultima volta nel 1984. Per questo, la Santa Sede ha chiesto formalmente la modifica del disegno di legge.
I sacerdoti potrebbero essere perseguitati?
Secondo la Santa Sede “alcuni contenuti della proposta legislativa avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli”.
Tra le preoccupazioni espresse dal Vaticano sono le possibili ripercussioni giudiziarie a carico di fedeli e sacerdoti contrari, ad esempio, a matrimoni omosessuali, adozioni gay e cambio di sesso. Ma il ddl Zan non prevede alcuna sanzione per i sacerdote che vorranno fare “campagna” contro l’equiparazione dei diritti delle coppie omosex rispetto ai diritti della cosiddetta famiglia tradizionale.
Le scuole private “costrette” a celebrare la giornata contro l’omotransfobia?
Il Vaticano è molto critico su questo passo perché le scuole cattoliche non sarebbero esentate dalle attività previste in occasione della Giornata nazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. Alessandro Zan, ha però ben spiegato che l’articolo 7 “si inscrive in un quadro segnato dal principio di autonomia scolastica, che è generale e si applica a tutte le scuole, pubbliche e private”
Le Leggi in Europa
Nella maggior parte d’Europa i crimini d’odio sono estesi a orientamento sessuale e identità di genere. L'Italia è tra pochi paesi a non avere una legislazione ad hoc:
La Norvegia ha avuto una prima legge addirittura nel 1981 (e dal 2020 ha incluso per i reati d’odio anche le persone transgender e i bisessuali).In Francia la prima legge risale al 2003, con il presidente di centrodestra Chirac. Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, è stato multato per aver paragonato omosessualità e pedofilia.Nel Regno Unito il fenomeno ha rilevanza penale nell’ambito dei cosiddetti hate crime.In Svezia chi minaccia o discrimina gli omosessuali rischia fino a 4 anni di carcere e dal 1995.Sono previste sanzioni anche in Spagna.Ma sono solo alcuni esempi: esistono tutele (e quindi sanzioni) per questo genere di discriminazione anche in Grecia, Portogallo, Belgio, Finlandia, Croazia, Irlanda, Islanda, Albania, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Kosovo ed in Ungheria.
Questo è un esempio di democrazia, di uno stato democratico
La legge che avrebbe dovuto alzare le barriere a difesa della comunità gay e trans contro i crimini d’odio, non solo non passa ma viene definitivamente demolita.Non può essere ripresa l’indomani come se bastasse girare una pagina e amici come prima.Il regolamento del Parlamento prevede che quel testo venga stracciato e che si possa ricominciare a parlare del tema, ma non prima di sei mesi e comunque con una nuova legge, ripartendo dalla Camera. Dunque non c’è speranza. È un addio alla legge Zan.Ognuno da colpa all’altro
È la fine di una guerriglia parlamentare perché è quella l’impressione a vedere le reazioni.In Aula c’è il fronte di destra che esulta con applausi a scena aperta e c’è chi invece esce carico di rabbia per un esito inaspettato.Il risultato è un continuo rimpallo di responsabilità fra i partiti. Monica Cirinnà (Pd) ha commentato: "Il centrosinistra della maggioranza Conte è finito, adesso il centrosinistra riparte da Pd, Leu, Sinistra Italiana e M5s. La maggioranza Conte è sotterrata".E Italia Viva? "Non lo so, guardate il pallottoliere e vedete voi, non lo so davvero. Ma questo deve essere chiaro: il testo è finito, non c’è possibilità di recuperarlo né in aula né in commissione".Più netto il papà della legge, il deputato democratico Alessandro Zan, che punta il dito contro renziani e berlusconiani: "Una forza politica si è sfilata dalla maggioranza che c'era alla Camera e ha flirtato con la destra sovranista, inoltre Forza Italia si è compattata con la destra sovranista dimostrando di non essere una forza liberale vicina ai diritti".La forza politica non citata è Italia Viva. La stessa a cui fa riferimento la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi.Accuse rimandate al mittente dal Presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone: "Pd e M5s dovrebbero passarsi la mano sulla coscienza e ammettere che hanno sbagliato a costringere il Senato a contarsi col voto segreto e dovrebbero chiedere scusa ai tanti cittadini che aspettavano questa legge, che ormai rischia di non vedere la luce in questa legislatura".
Faraone dunque non ci sta e, anzi, rilancia la responsabilità proprio nei confronti di chi "ha compiuto l’errore di trasformare una battaglia di civiltà in uno scontro ideologico fra partiti per guadagnare qualche punto percentuale nei partiti”.C’è grande amarezza anche e nel Movimento 5 Stelle. Dopo la sconfitta, tra le prime a lasciare l’Aula è la senatrice Alessandra Maiorino, che lancia una stoccata agli alleati del Pd: "Politicamente io sono nuova, questo è il mio primo mandato, ma è tutto molto strano, abbiamo lasciato che le cose fossero condotte da chi aveva più esperienza di noi, anche più credibilità nel mondo Lgbt come il Pd e questo è stato l’esito. Sono molto amareggiata".Nel frattempo non bisogna dimenticare che è ancora in corso la proposta del centrodestra di governo
Resta depositata in commissione giustizia al Senato la proposta del centrodestra firmata dalla forzista Licia Ronzulli e da Matteo Salvini.
È un disegno di legge unitario sull'omofobia di tutto il Centrodestra che sta in maggioranza, un testo alternativo a quello condiviso da tutto il Centrosinistra e a firma Alessandro Zan.Se la Commissione Giustizia del Senato ha comunque deciso 12 voti a 9 di scegliere proprio il testo Zan come base di partenza della discussione, tra le proteste di tutto il Centrodestra, compreso Fratelli d'Italia, la polemica comunque va avanti perché riguarda anche le differenze sostanziali che ci sono fra le due proposte.Secondo lo stesso Zan, il disegno di legge del Centrodestra è pasticciato e rischia di entrare in conflitto con la legge Mancino, che già interveniva sui reati fondati su etnia, nazionalità e religione. Il Centrodestra invece rivendica come necessaria la sua azione proprio per superare le polemiche su un testo che ritiene ideologico e anche pericoloso sul fronte del rispetto del diritto di opinione.Le principali differenze riguardano la questione del gender, nel testo di Centrodestra non ci sono riferimenti ai transgender e soprattutto non esiste la specifica contenuta in quello Zan sull'identità di genere, come identificazione percepita di se anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Una delle accuse del Centrodestra è che questo, riguardando anche i minori, non sia accettabile. L'altro punto di divergenza importante è che mentre Zan interviene sull'articolo 604bis del codice penale, potenziando la già prevista aggravante per odio, il Centrodestra agisce sull'articolo 61 che prevede aggravanti generiche da cui anche la differenza delle pene, raddoppiate dal DDL Zan e aumentate invece di un terzo dal testo del Centrodestra.Ora il centrodestra rilancia. Il testo propone una modifica all’articolo 61 del codice penale, introducendo le aggravanti legate a etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e disabilità.Gli altri due articoli, invece, descrivono «l’apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di “blindatura”», che limita, cioè, «il potere del giudice di bilanciare tale aggravante con eventuali attenuanti».Ecco il testo del disegno di legge presentato del centrodestra di governo, che prevede un'aggravante rispetto a quelle previste dall'art. 61 del Codice penale.






