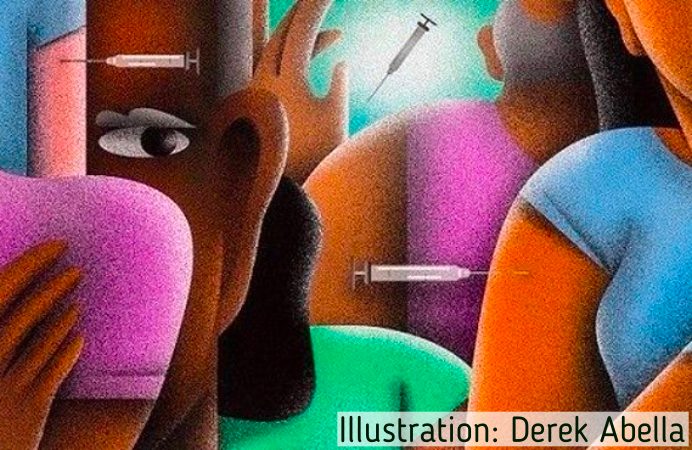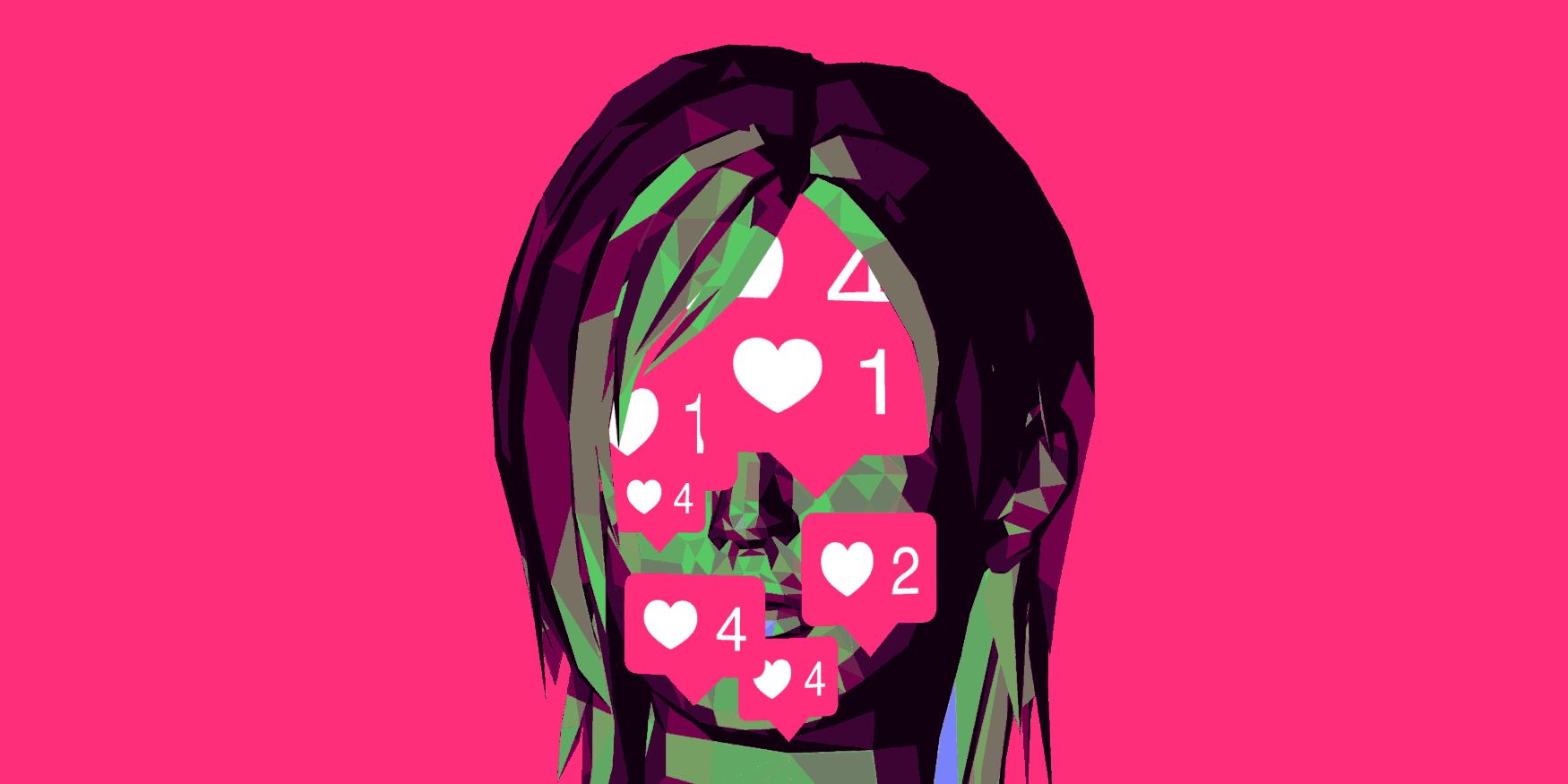L'Unione Sovietica e il Pci. Relazioni difficili
Agli occhi di molti giovani il rapporto del PCI con l’URSS appare come una macchia indelebile. Altri lo mitizzano e ne esaltano anche gli aspetti più negativi, evitando di domandarsi quanto ha pesato la lunga giustificazione del retaggio staliniano nella rapida disgregazione di quello che era stato un grande partito ben radicato tra i lavoratori.
È necessario distinguere le caratteristiche di questo rapporto nel corso del lungo periodo. Ad esempio non c’è dubbio che negli anni della formazione del nucleo centrale del partito comunista d’Italia, cioè tra l’entrata in guerra dell’Italia e il congresso di Livorno, il legame (peraltro ancora saltuario) con il partito bolscevico non fu un peso, ma un aiuto importante per il partito in formazione, che beneficiava della grande popolarità della rivoluzione d’Ottobre tra le masse operaie, compresa una parte non trascurabile della base del partito socialista. Anche se tradurre in legami concreti il sentimento espresso dal canto E noi farem come la Russia sarebbe apparso presto ben più difficile di quanto immaginato.
 Nei primi anni dopo la fondazione, spesso, il gruppo dirigente del PCd’I non condivise le critiche e i suggerimenti che arrivavano dall’Internazionale, anche se erano espressi dallo stesso Lenin, o da Trotskij ed altri protagonisti dell’Ottobre. Erano in genere resistenze dovute all’estremismo di molti dirigenti, e provocarono non pochi danni ritardando o ostacolando la tattica per recuperare almeno una parte dei quadri socialisti di sinistra che al momento della scissione di Livorno erano stati respinti dall’ultimatismo dei rappresentanti dell’Internazionale. Tuttavia erano divergenze considerate fisiologiche, da risolvere non con le espulsioni ma col dibattito nell’Internazionale in cui era grande ma non schiacciante il peso della sezione russa.
Nei primi anni dopo la fondazione, spesso, il gruppo dirigente del PCd’I non condivise le critiche e i suggerimenti che arrivavano dall’Internazionale, anche se erano espressi dallo stesso Lenin, o da Trotskij ed altri protagonisti dell’Ottobre. Erano in genere resistenze dovute all’estremismo di molti dirigenti, e provocarono non pochi danni ritardando o ostacolando la tattica per recuperare almeno una parte dei quadri socialisti di sinistra che al momento della scissione di Livorno erano stati respinti dall’ultimatismo dei rappresentanti dell’Internazionale. Tuttavia erano divergenze considerate fisiologiche, da risolvere non con le espulsioni ma col dibattito nell’Internazionale in cui era grande ma non schiacciante il peso della sezione russa.
La situazione cambia nel giro di pochi anni per la coincidenza di molti fattori, primo tra tutti la vittoria del fascismo che rende tutto più difficile anche prima della formale soppressione del partito comunista che avviene per decreto nel novembre 1926. Presto peserà anche l’isolamento di Gramsci, che era diventato nel 1924 segretario del partito, ma che meno di due anni dopo ha espresso critiche severe alla politica staliniana in una lettera al partito sovietico e all’internazionale che verrà censurata due volte, a Mosca e anche in Italia: lo stesso Ufficio Politico del PCd’I riunito subito dopo il suo arresto, ritira la lettera impedendo che possa circolare tra i principali partiti dell’ internazionale. Togliatti, che accettò quella censura, negherà l’esistenza della lettera fino agli anni Sessanta.
L’eliminazione di Gramsci voluta dal regime fascista rafforza involontariamente il legame tra i comunisti italiani e il PCUS in un periodo in cui si sta consolidando il potere di Stalin in forme ben più gravi di quelle denunciate nella Lettera. È un legame tuttavia che appare indispensabile ai militanti braccati, incarcerati e condannati a lunghe pene detentive o anche solo licenziati dalla fabbrica in cui lavoravano e costretti alla clandestinità. È ben accolto l’aiuto del Soccorso Rosso internazionale, anche se inevitabilmente sorretto quasi esclusivamente dall’URSS dato che i comunisti negli anni Venti e Trenta sono perseguitati da quasi tutti i governi del mondo.
D’altra parte l’involuzione dell’Unione Sovietica sfugge ai militanti isolati in Italia o in esilio anche perché la fraseologia del movimento comunista continua ad essere rivoluzionaria anche negli anni Trenta quando Stalin cerca intese con l’imperialismo franco-britannico prima e con la Germania nazista più tardi. Così molti militanti del PCd’I vanno a combattere in Spagna animati da un reale e sincero antifascismo, e alcuni di loro come Ilio Barontini vanno poi nell’Etiopia occupata a portare la loro esperienza alle guerriglie locali. La partecipazione di tanti comunisti italiani alla lotta armata contro il golpe di Francisco Franco (senza ovviamente un bilancio della sconfitta, e tantomeno delle repressioni di trotskisti veri o presunti) fornirà materiale per un’epica antifascista che sarà usata per mettere al bando ogni tentativo di consolidare il carattere classista di una parte non trascurabile della resistenza.
Qualsiasi critica all’URSS viene respinta, sono dimenticati o “perdonati” i dubbi che alcuni dirigenti prestigiosi come Umberto Terracini o Camilla Ravera avevano avuto sul Patto Ribbentrop-Molotov, e che saranno a lungo ignorati dalla base. I pochi che avevano dubitato della strategia staliniana nei primi terribili anni di guerra sono stati recuperati grazie agli spettacolari successi dell’Armata Rossa che suscitano grandi speranze in tutta l’Europa occupata. Pochi sanno che centinaia di comunisti e antifascisti italiani rifugiatisi nell’Unione Sovietica per sfuggire alla repressione sono finiti nel GuLag per una frase critica o un voto dato anni prima all’opposizione di sinistra.
Il “partito nuovo” che cresce sull’onda delle vittorie sovietiche e per il ruolo dei comunisti nella resistenza non assomiglia molto a quello messo al bando dal fascismo, e può avvalersi di un gran numero di quadri formatisi nell’esilio in Francia e nella guerra di Spagna, che formano un apparato impegnato a contrastare col proprio prestigio di combattenti le spinte “estremiste” (come venivano chiamate le perplessità sulla collaborazione di classe con la monarchia e i partiti borghesi e conservatori).
Per farlo efficacemente bisognava far leva anche sulla mitizzazione dell’URSS e del suo “infallibile capo” e di come Togliatti gli era stato vicino. E per questo il partito rimuove ogni dubbio di fronte all’esplosione della crisi jugoslava, alla rivolta operaia di Berlino Est, e poi – dal 1956 in poi – alle periodiche proteste in Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e alle brusche destituzioni di dirigenti (non sempre con eliminazione fisica ma sempre senza diritto all’autodifesa). Ogni anno arrivano nuovi iscritti scarsamente politicizzati che rimpiazzano largamente quelli che sono usciti o che rimangono sottoutilizzati: vengono indottrinati da brevi corsi che alimentano una visione acritica.
Nella grossa sezione romana in cui ho militato tra il 1956 e il 1967, su ogni crisi del “socialismo reale” si apriva un dibattito non facile, ma appassionato per la presenza di decine di “quadri storici” del partito degli anni Trenta e Quaranta e al tempo stesso anche di esponenti di primo piano delle generazioni successive come Ingrao o Natoli o Ledda. Tra i vecchi spiccava Paolo Robotti, il cognato di Togliatti verso cui aveva un rancore profondo perché non era intervenuto per sottrarlo al carcere staliniano. Ma era rimasto tenacemente stalinista, nonostante la sua esperienza personale. E offriva una sponda a chi sosteneva che le crisi nell’est europeo (e anche nell’URSS che nel 1964 aveva destituito Chrusciov con motivazioni inverosimili) erano solo il frutto di “manovre della CIA”, senza domandarsi perché mai solo la CIA aveva successo nello scatenare proteste di massa. Ricordo l’ingenuità di un vecchio compagno che spiegava che ogni crisi del sistema sovietico era stata organizzata a Washington per far perdere voti al PCI nelle prossime elezioni…
Nonostante il peso dei nostalgici, la sezione rimase a lungo in posizione critica grazie all’arrivo di molti giovani: nell’XI congresso del 1966, il primo senza Togliatti, tutti i delegati eletti al congresso di federazione si erano caratterizzati votando alcuni emendamenti alle Tesi proposti da Aldo Natoli (uno dei pochi dirigenti capaci di una riflessione seriamente critica sull’involuzione dell’URSS e dello stesso PCI). Ma quella sezione era un’eccezione. In realtà il grosso della base del partito non condivise la prima presa di posizione critica dell’Ufficio Politico sull’intervento delle truppe del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia nel 1968 e ancor più la condanna dell’uso dell’esercito in Polonia, sospettando che fossero dettate da prevalenti esigenze di politica italiana. Così il crollo dell’Urss e del suo sistema arrivò inaspettato e distruttivo per chi non aveva voluto capire il significato delle prime rivolte di massa, travolgendo presto anche il gruppo dirigente che non aveva avuto il coraggio di discutere francamente sulla crisi che avanzava e di trasformarsi in un punto di riferimento nel dibattito internazionale.
E il rifiuto di ricostruire le fasi della involuzione dell’Unione Sovietica esaminando la sua storia facilitò anche il sostanziale fallimento della “nuova sinistra” che, soprattutto per influenza del maoismo, fu incapace di agire sulle contraddizioni interne del PCI tentando una tattica di fronte unico, e puntò invece spesso sullo scontro verbale esasperato con quello che veniva considerata semplicemente una propaggine dell’imperialismo dei “nuovi zar” e che invece continuava a raccogliere militanti con un forte radicamento nella classe operaia.