Le conseguenze economiche dei decenni berlusconiani
Trent'anni di berlusconismo lasciano una cicatrice profonda sulla nostra vita civile, culturale e politica. Le istituzioni però, anche grazie a una buona dose di fortuna, hanno complessivamente tenuto. Possiamo solo sperare che reggano anche in questa nuova fase, quella del governo più a destra che si sia mai visto in tutta l’Europa occidentale, finora, e che è stato il suo ultimo lascito all’Italia.
“Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano”.
[Silvio Berlusconi, 26 gennaio 1994]
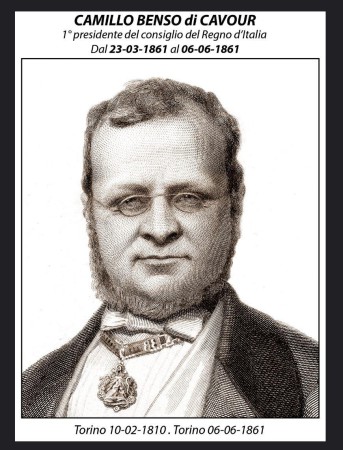
La proclamazione del lutto nazionale ha inoltre palesato, una volta di più, come la sua figura abbia umiliato e vilipeso le istituzioni della Repubblica: finora nessun ex presidente del Consiglio aveva avuto questo onore. In 162 anni di storia dell’Italia unita, l’unico altro caso è quello di Cavour.
Da Cavour a Berlusconi. Lì dove la questione non è, ovviamente, azzardare un confronto sull’importanza dei due personaggi, cioè l’impatto da loro esercitato sulla politica e la società italiane. Esercizio peraltro futile, data la diversità fra i due e la distanza storica. E comunque l’impatto di Berlusconi è stato enorme. Bensì il dato, elementare, che Cavour è stato un padre della patria (anzi, si può dire che Cavour la nostra patria ha contribuito a crearla più di chiunque altro, assieme a Garibaldi), Berlusconi una figura divisiva: amato da molti, sempre meno con il passare degli anni; inviso a tanti. Un personaggio che ha spaccato l’Italia in profondità – tutto il contrario di Cavour.
Qui però non vogliamo guardare alle conseguenze della sua opera sul piano civile, culturale, o politico. Sono state e sono già molto discusse e alcune come accennato si sono manifestate perfino nei giorni della sua morte. L’obiettivo di questo intervento è esplorare un ambito in cui il Berlusconi politico ha esercitato un forte impatto sulle sorti del Paese, forse meno evidente o scontato, ma almeno altrettanto centrale: l’economia.
 2. I fatti essenziali
2. I fatti essenziali
Dopo una carriera imprenditoriale di grande successo in diversi settori (edilizia, editoria, televisione, calcio), ma giocata a volte ai confini della legalità e non priva di ombre o zone grigie, Berlusconi «scende in politica» e diventa presidente del Consiglio nel 1994 (per otto mesi) e poi ininterrottamente dal 2001 al 2006 (Berlusconi II e III) e ancora dal 2008 al 2011 (Berlusconi IV). A partire dal 1994, anche quando non era premier è stato o il leader riconosciuto dell’opposizione di centrodestra (1995-2001 e 2013-2018, ma per alcuni aspetti anche oltre) oppure un partner importante della coalizione di governo (dal novembre 2011 al novembre 2013, governo Monti e prima fase del governo Letta; 2021-2022, governo Draghi).
Nell’epoca dell’«egemonia berlusconiana», soprattutto dal 2001 al 2011, l’Italia è declinata rispetto agli altri Paesi avanzati e al mondo intero: in confronto ai nostri vicini e partner, noi siamo diventati un Paese più povero e più arretrato (o se vogliamo, meno ricco e meno avanzato). Prendiamo i dati della Banca Mondiale. Nel 1993, il Pil per abitante dell’Italia risulta del 29% più alto di quello dell’Unione europea (confini attuali, a parità di potere d’acquisto). Nel 2001, il nostro Pil è ancora superiore del 24%. Nel 2011, il divario si è ridotto ad appena il 6%. Questo declino sarebbe poi proseguito: nel 2015 il Pil per abitante dell’Italia diventa inferiore alla media europea; di recente la situazione si è stabilizzata e attualmente (2021) il divario a nostro sfavore è del 5%. Insomma, dagli anni Novanta a oggi l’Italia è passata da Paese significativamente più ricco nel consesso europeo, a Paese un po’ più povero: come mostrato, il grosso di questo cammino all’indietro si è prodotto nel periodo in cui Berlusconi era premier.
Nella produttività dell’industria (valore aggiunto per addetto, costruzioni comprese) osserviamo un movimento simile, per certi versi ancora più accentuato. Le prime stime comparabili partono dal 1995: a quella data, siamo sopra la media dell’Unione europea di ben il 41%. Nel 2001 il vantaggio è sceso al 30%. Nel 2011 siamo ad appena l’8%. Qui oggi abbiamo ancora un leggero vantaggio, di appena il 3%.
Di nuovo, il grosso della perdita di produttività si è registrato durante i governi Berlusconi, in misura anche maggiore rispetto al Pil pro-capite (per entrambe le misure, miei calcoli dal sito della Banca mondiale).
Quanto al debito pubblico, questo nel solo 1994 ha fatto un balzo di sei punti rispetto al Pil: dal 115 al 121%; nel 2001 era stato ridotto al 108%; quindi, con i governi Berlusconi II e III, si mantiene più o meno stabile; nel breve intervallo del 2007 (secondo governo Prodi) scende dal 106 al 103%; ma poi, con il governo Berlusconi IV fa un altro balzo, arrivando di nuovo a sfiorare, nel 2011, il 121% (cfr. E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia , Il Mulino, 2015, Appendice statistica). Certo, durante il Berlusconi IV c’era la crisi economica internazionale.
Significativo però è che, anche quando la crisi non c’era, i tagli più consistenti al nostro debito pubblico siano stati operati dal centrosinistra, non dal centrodestra. Quanto alla riduzione della pressione fiscale, che pure piaccia o meno avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello delle politiche berlusconiane, ebbene: quella complessiva (entrate fiscali rispetto al Pil) era nel 2001 al 40,3%; nel 2006, al termine di cinque anni ininterrotti di governi Berlusconi, risulta immutata, anzi leggermente più alta, 40,6%; nel 2008 la troviamo lievitata al 41,7%, vero; ma da lì, dopo altri tre anni di governo Berlusconi, risulta ancora immutata, anzi in leggero aumento, al 41,9% nel 2011 (dati Ocse riportati in E. Marro, Gli italiani e le tasse: 50 anni di pressione fiscale spiegati in 5 grafici, su «Il Sole - 24 Ore»).
Va detto invece che, in quegli anni, non vi è stato un incremento della disuguaglianza (per come misurata dall’indice di Gini), che anzi dal 2000 al 2006 diminuisce (da 35,3 a 33,7). La disuguaglianza in Italia comincia a salire nel 2008, come conseguenza della crisi internazionale, incrociando solo l’ultima fase dell’egemonia berlusconiana: l’indice di Gini balza da 32,9 nel 2007 a 35,2 nel 2012. In modo altalenante, crescerà poi ancora fino al picco di 35,9 nel 2017 (di nuovo, si veda il sito della Banca mondiale).
La corrispondenza fra questi dati sull’Italia – quelli su Pil e produttività, fra tutti – e le date di Silvio Berlusconi al governo non è una mera coincidenza. Di seguito proverò a spiegare che, quando è stato premier, Berlusconi con le sue scelte e non scelte politiche ha favorito il declino dell’Italia, cioè il nostro impoverimento relativo.
Tutto il contrario, per paradosso, dello slogan con cui si era presentato sulla scena politica, nel video del 26 gennaio 1994: «un nuovo miracolo italiano». Così come è stato l’opposto, nel complesso, l’esito in quanto a libertà civili e politiche. Berlusconi è stato nei fatti l’esatto contrario della sua narrazione. Eppure, a quella narrazione molti hanno creduto e forse credono ancora. In fondo, è stato un grande piazzista.
 3. Il «modello» di base
3. Il «modello» di base
In realtà, quello che innanzitutto risalta della sua politica economica, da premier, è l’immobilismo. A fronte di un gran parlare di riforme, addirittura già dalla sua discesa in campo di «rivoluzione liberale» (espressione poi fatta propria, nel 1998, dall’allora segretario dei Ds e poi premier Massimo D’Alema e, in seguito, riecheggiata più volte anche nel Partito democratico: risale del resto a Piero Gobetti, 1922), Berlusconi ha fatto molto poco e, quel poco, andava nella direzione opposta a quanto sarebbe stato auspicabile.
La riduzione della pena per il falso in bilancio (approvata nel 2002) e l’accorciamento dei tempi della prescrizione nei processi penali (varata nel 2005) sono casi da manuale di leggi ad personam, cioè a suo interesse e tutela dai processi in corso (peraltro, la seconda è stata anche efficace).
Ma sono agli antipodi di ciò di cui aveva e ha bisogno l’Italia, il cui sistema capitalista – per tradizioni etiche, morfologia di impresa e motivi istituzionali, fra cui l’incertezza del diritto – è particolarmente permeabile all’illegalità: con queste leggi, l’illegalità anziché venire corretta, risulta protetta e incentivata. Lo stesso vale per i due condoni da lui approvati, nel 2003 (Berlusconi II, condono edilizio e fiscale) e poi ancora nel 2009 (Berlusconi IV, condono per i capitali che rientrano dall’estero).
L’abolizione nel 2001 dell’imposta di successione e donazione, già durante i primi mesi di governo, con la quale l’Italia divenne un unicum, in tutto il mondo avanzato, e la successiva abolizione dell’imposta sulla prima casa, allora Ici (subito dopo il suo ritorno al governo, nel 2008) e quindi l’introduzione di una flat tax, o cedolare secca, sugli affitti (marzo 2011) sono invece nella sostanza promesse mantenute, tutto sommato non ad personam (se non «postume», nel caso dell’imposta di successione). Ma hanno l’effetto di ridurre le tasse anziché sui fattori produttivi (il lavoro, il capitale investito), cosa di cui forse vi era necessità, sulla ricchezza immobilizzata e sulle rendite, che in questo modo vengono incentivate.
Ricordiamo che la pressione fiscale complessiva rimase, nei suoi anni al governo, pressoché invariata (venne quindi redistribuita, spesso a carico dei più deboli o in modo meno razionale: i comuni ad esempio aumentarono le tasse e addizionali locali per fare fronte alle mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’Ici). Inoltre, specie l’abolizione dell’imposta di successione va in direzione esattamente opposta ai discorsi sulla «meritocrazia», almeno per come andrebbero declinati: proprio quella di successione è, tipicamente e storicamente, un’imposta «liberale», volta a garantire a quante più persone pari condizioni di partenza e a rompere l’immobilismo sociale.
Infine, ricordiamo che su questo la retorica berlusconiana ha influenzato e fatto breccia anche nel centrosinistra: nel 2000 il secondo governo Amato aveva notevolmente ridotto l’imposta di successione, al livello più basso fra tutte le grandi economie europee, ed è questo il livello cui si trova ancora oggi (reintrodotta da Prodi nel 2007); allora questo fu fatto proprio per togliere argomenti al centrodestra di Berlusconi dato per vincente (vincerà). L’imposta sulla prima casa sarà poi reintrodotta da Monti, si chiamerà Imu, ma verrà abolita di nuovo da Enrico Letta, nell’autunno del 2013, in un governo di «larghe intese» che ha per partner principale il Pdl di Silvio Berlusconi (prima che questi rompesse).
Questi interventi si sono poi accompagnati ad un clima diffuso, da lui stesso largamente alimentato, di diffidenza verso le regole, e verso lo stato di diritto, e di lassismo sul piano fiscale e normativo.
Quanto al lassismo, va detto che questa impostazione aveva già caratterizzato l’ultima fase della Prima Repubblica. Di fronte a un assetto tributario irrazionale e gravoso, e a un’elevata evasione, anziché affrontare l’impresa di riformare il fisco una buona parte dello schieramento politico preferisce chiudere un occhio sull’evasione, vista come valvola di sfogo. Lo stesso vale per l’indulgenza sulla mancata applicazione della normativa, ad esempio quella sul lavoro.
È questa anche una strategia di sviluppo, a suo modo, come già notava Marcello de Cecco (L’economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli dello sviluppo italiano, Roma, Donzelli, 2000): le imprese, pagando in nero i lavoratori o non pagando ed eludendo le tasse, o non rispettando le regole sulla sicurezza, hanno in effetti meno costi. Non competono però certo sulla qualità, in questo modo. Di fatto, notava de Cecco già negli anni Novanta, è un «modello» di sviluppo da Paese arretrato.
Ed è un modello che, se pure poteva ancora «funzionare» ai tempi della Prima Repubblica, non ha più alcuna logica per l’Italia negli anni Duemila: anni caratterizzati dall’affacciarsi sui mercati mondiali di giganti asiatici con un costo del lavoro incomparabilmente più basso del nostro e in più, per l’Europa, dall’integrazione dei Paesi dell’ex blocco sovietico, che pure hanno costi inferiori (anche fiscali) e dove è molto facile delocalizzare dall’Italia.
Tantopiù vero, questo discorso, dal momento in cui dal 1° gennaio 1999 noi siamo entrati nell’euro, diventato poi moneta corrente dal 1° gennaio 2002. Uno dei pilastri del modello di competizione sui costi praticato fino ad allora, cioè la svalutazione della lira (e l’inflazione, e il debito), semplicemente non esisteva più. L’euro, per la verità, in confronto al dollaro andò incontro a un forte processo di svalutazione dal 1999 fino ai primi mesi del 2002, per poi rivalutarsi molto, toccando l’apice da marzo ad agosto del 2008 e poi ancora alla fine del 2009: resta il fatto che tutto questo non dipendeva più da noi.
A quel punto, non vi era altra strada: noi avremmo dovuto dotarci di istituzioni, regole e standard sul livello degli altri Paesi avanzati con cui condividevamo la moneta comune, e con cui dovevamo e dobbiamo convergere su debito, deficit e tassi di inflazione; a cominciare dalla Germania. Detta altrimenti: non dovevamo e non potevamo più competere sui costi; ma sulla qualità e sull’innovazione, superando peraltro la specializzazione nei settori leggeri, a più bassa produttività, e la piccola dimensione.
Questo voleva dire riforme che promuovessero la concorrenza, che garantissero lo stato di diritto riformando la giustizia e migliorando anche la politica, incentivi per la crescita dimensionale, l’efficienza gestionale e il cambiamento tecnologico delle imprese private, una strategia di razionalizzazione e innovazione anche per le imprese pubbliche, investimenti per rafforzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione, e investimenti nell’istruzione e nella ricerca, un’area dove peraltro registriamo la più bassa percentuale di spesa in rapporto al Pil fra i grandi Paesi avanzati (solo la Spagna era leggermente più bassa di noi, ma ci ha superato nei primi anni Duemila). Investimenti da finanziare: altro che «meno tasse per tutti»!
Nulla di questo è stato fatto dai governi Berlusconi. Anzi. Le sole norme che hanno effettivamente aperto un po’ i mercati e migliorato la concorrenza si devono al centrosinistra, in particolare (quelle con i maggiori benefici per cittadini e consumatori) nel 2006 e nel 2007 a Pierluigi Bersani, quando era ministro per lo Sviluppo economico con il Prodi II.
Berlusconi ha scelto invece la strada, più facile, di proseguire lungo il modello precedente; anzi accentuandolo, addirittura, e spesso per interessi personali. Mentre peraltro ha continuato a depauperare di risorse la pubblica amministrazione, l’istruzione e la ricerca. Scrivo «facile» perché questa era anche, elettoralmente, la strategia che pagava di più, nell’immediato (così come avevano pagato, a breve termine, le politiche di indebitamento e lassismo della tarda Prima Repubblica): l’abolizione dell’Ici, ad esempio, fu molto popolare.
Ma era una strada che minava i fondamentali della crescita dell’Italia – etica, istruzione e ricerca, istituzioni nelle loro diverse articolazioni e accezioni. Quei fondamenti di cui avevamo e abbiamo invece maggiore necessità, specie dopo l’ingresso nell’euro e nel mondo globalizzato. Le politiche economiche di Berlusconi, insomma, erano fuori tempo rispetto alla fase storica in cui l’Italia era entrata. Anzi remavano nella direzione opposta. A questo tratto, «strutturale» per così dire (era in fondo l’essenza della sua politica) se ne sono aggiunti altri più contingenti, se vogliamo, di per sé forse non essenziali, ma che pure hanno segnato la nostra storia.
 4. La mistificazione sull’euro
4. La mistificazione sull’euro
Il primo è il modo in cui fu gestito il passaggio all’euro. La parità della lira fissata a suo tempo (dicembre 1998), 1.936,27 lire per un euro, in un serrato negoziato europeo che per l’Italia ha avuto come protagonisti oltre a Carlo Azeglio Ciampi (ministro del Tesoro), Mario Draghi (direttore generale del Tesoro) e Pierluigi Ciocca (vicedirettore della Banca d’Italia), era adeguata alla situazione macroeconomica dell’Italia e alle quotazioni che la lira aveva allora rispetto al marco. Non era sopravvalutata, come invece ha fatto credere allora e negli anni successivi una pubblicistica soprattutto di destra (ma in parte anche di sinistra). L’Italia insomma non entrò nella moneta unica con un cambio per noi troppo alto (una lira forte), con conseguente danno per le nostre esportazioni, come si sentiva e si sente ripetere.
Negoziato dal centrosinistra, l’euro divenne moneta corrente all’inizio del secondo governo Berlusconi, il 1° gennaio 2002. Contemporaneamente, si accentuò il declino economico del Paese. Da parte della maggioranza di centrodestra si diede la colpa proprio alla moneta unica, che avrebbe danneggiato le nostre esportazioni. Di più, specie nell’economia informale (ma non solo), molti operatori cercarono piuttosto di praticare un cambio vicino alle 1.000 lire per un euro, con conseguente fiammata inflattiva, presunta (non rilevata dall’Istat), che può aver ridotto la domanda interna. Pure di questo, si diede la colpa alla parità che era stata negoziata. E anche in maniera contraddittoria: Berlusconi arrivò a scrivere, in un rotocalco propagandistico inviato agli italiani durante la campagna elettorale del 2006, che la parità avrebbe dovuto essere addirittura di 1.500 lire per un euro, cioè una lira fortissima insostenibile per le nostre esportazioni.
Ma al di là di singoli aspetti, più tecnici e forse più ostici per il grande pubblico, in generale la destra fece passare l’idea che le difficoltà economiche del Paese fossero dovute all’euro e al modo in cui il centrosinistra vi era arrivato (e l’egemonia della destra su questa interpretazione fu talmente forte che persino chi la propugnava da sinistra alla fine si trovò proiettato in quell’orbita: uno dei suoi più noti divulgatori, Alberto Bagnai, è dal 2018 parlamentare, e poi anche responsabile Economia, della Lega). Lo stesso Giulio Tremonti, il ministro dell’Economia e delle Finanze di Berlusconi (2001-2006 e poi anche 2008-2011; nel 2005-2006 fu anche vicepresidente del Consiglio), replicò e avallò questo racconto, peraltro mentre in diverse occasioni negava i dati sul declino economico dell’Italia.
Ma, a parte il punto che evidentemente siamo sempre, ancora, nello stesso modello di sviluppo non più praticabile (la competizione di costo), per quel che riguarda la fiammata inflattiva ricostruendo i fatti scopriamo che fu in realtà proprio Tremonti il primo a praticare il cambio di 1.000 lire per un euro: e per decreto, e ancora prima che l’euro entrasse in vigore! Il 28 dicembre 2001, il suo ministero, in vista dell’imminente introduzione della moneta unica, elevò la giocata minima del lotto e di altre scommesse da 1.000 lire a un euro.
C’è di più. In quegli stessi mesi, Tremonti non rese mai operative le commissioni di controllo provinciali sui prezzi e non fece applicare il doppio prezzo (in lire e in euro), due strumenti previsti dai precedenti governi di centrosinistra proprio per evitare indebiti aumenti. Insomma, l’impennata dei prezzi, che pur non rilevata dall’Istat può esserci stata nei settori informali dell’economia e nei servizi al dettaglio, fu responsabilità del governo Berlusconi.
E difatti beneficiò i ceti elettorali che tradizionalmente votavano a destra, mentre andò a detrimento dei lavoratori a reddito fisso e dei pensionati. Ma Berlusconi e Tremonti riuscirono nel capolavoro di addossare la responsabilità al centrosinistra e di fare credere a molti che fosse così, e di coprire in questo modo anche l’inadeguatezza della loro politica (e visione) economica.
Fra gli episodi paradossali della politica economica berlusconiana, questo è forse il meno noto. Altri fatti e dati sono meglio conosciuti e anch’essi costituiscono circostanze aggravanti.
 5. Le aggravanti
5. Le aggravanti
Un’aggravante discende dall’approccio di Berlusconi al capitalismo e alle relazioni di impresa: un approccio relazionale, cioè spesso amicale e politico (e non di mercato), praticato sin dalle origini della sua carriera imprenditoriale. Tale approccio, da un lato, non gli ha consentito di liberalizzare davvero il Paese e di favorire una concorrenza ben regolata (a provarci furono invece i governi di centrosinistra), limitando la sua azione a riduzioni fiscali sulla rendita o a norme ad personam, come abbiamo visto. Dall’altro, lo ha condotto a scelte fallimentari di politica industriale, privilegiando i rapporti personali rispetto alle competenze o al merito dei problemi. Qui forse il caso esemplare è la vicenda di Alitalia.
La compagnia di bandiera entra in crisi alla metà degli anni Novanta. Dopo un decennio di difficoltà e perdite, la soluzione sembra finalmente vedere la luce nel 2007, durante il secondo governo Prodi, con l’accordo per la vendita alla compagnia franco-olandese Air France-Klm. Ma tornato al governo nel 2008 Berlusconi, assecondando un certo umore nazionalistico, non ratifica l’accordo. Promuove al suo posto una cordata di «capitani coraggiosi», nazionali (la guida Colaninno e ne fanno parte Benetton, Caltagirone, Ligresti, Tronchetti Provera) che creano nel gennaio 2009 Cai, rilevando Alitalia e Airone (e con una partecipazione di Air France Klm del 25%). Ma l’operazione si rivela un fallimento, tanto che a un certo punto i franco-olandesi si defilano e Alitalia andrà incontro a nuove perdite, nuovi tentativi di vendita: il travaglio sembra concludersi solo nel 2023, quindici anni dopo, con la vendita a Lufhtansa e la definitiva liquidazione delle partecipazioni pubbliche.
Berlusconi, in sostanza, ha fatto perdere 15 anni. Solo la penale per la mancata vendita ad Air France-Klm è costata allora 1,7 miliardi di euro, senza contare un «prestito-ponte» del governo Berlusconi di 300 milioni di euro dichiarato aiuto illegittimo dalla Corte di giustizia europea, o gli 1,2 miliardi di debiti rimasti nella bad company statale al tempo della creazione di Cai; e ovviamente, senza contare le successive perdite di Alitalia, dell’ordine di centinaia di milioni all’anno.
Un altro aspetto riguarda la politica per il Mezzogiorno, che pure conta più di un terzo degli abitanti del Paese. Nessun altro Paese avanzato ha, oggi, una differenza così ampia e pronunciata, fra due aree storicamente e geograficamente ben definite. Al punto che per molti aspetti il divario Nord-Sud, cioè la mancata convergenza del Mezzogiorno in termini di reddito pro-capite, può essere considerato il principale fallimento dello stato unitario, nella sua storia. Dall’Ottocento a oggi, a giudizio di chi scrive le responsabilità principali sono da attribuire alla classe dirigente clientelare e all’assetto socio-istituzionale – alte disuguaglianza e istituzioni estrattive – del Mezzogiorno (rimando a E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro , Il Mulino, 2013). Come si è rapportato il Berlusconi politico di fronte a questo problema?
Nel costruire Forza Italia al Sud, Berlusconi si è appoggiato spesso proprio alla peggiore classe dirigente meridionale, di stampo clientelare, a volte legata a doppio filo alla criminalità organizzata (c’è stata in questo anche una certa continuità con la sua attività imprenditoriale). In aggiunta, Tremonti e l’asse con la Lega che hanno caratterizzato i suoi governi a partire dal 2001 hanno promosso l’idea che occorresse puntare sulla «locomotiva del Nord», di fatto abbandonando il Sud, giudicato ormai incapace di redimersi, a se stesso: in una situazione di ristrettezze finanziarie, bisognava investire sulla parte del Paese più forte e quindi in grado di crescere, nella speranza che questa si sarebbe tirata dietro anche il resto (Gianfranco Viesti ha osservato, giustamente, che tale politica è una trasposizione geografica della trickle-down economics di impianto neo-liberale, e difatti a quell’epoca non era seguita solo in Italia: Centri e periferie. Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX al XXI secolo, Laterza, 2021).
In realtà, dopo una stagnazione durata dalla metà degli anni Settanta alla metà anni Novanta, e che aveva interrotto il periodo di convergenza registrato durante il miracolo economico, negli ultimissimi anni del Novecento il Sud aveva ricominciato a dare segni di vitalità, sia economici, sia politico-sociali (e forse, se proseguita e sostenuta nel tempo, la «nuova Programmazione» promossa da Fabrizio Barca avrebbe potuto dare frutti).
Ma per avviare e consolidare una nuova stagione di convergenza ci sarebbero voluti investimenti nelle infrastrutture, economiche (di trasporto, telematiche) e anche sociali (scuole, asili), una classe dirigente all’altezza e profondamente rinnovata, nonché riforme istituzionali: a cominciare da una gestione centralizzata dei fondi europei per la coesione, che le singole regioni del Sud non sapevano (e non sanno) spendere, e dalla ricentralizzazione di alcune competenze fondamentali, dalla sanità all’istruzione avanzata, lì dove le regioni meridionali Sud si erano palesate molto deficitarie.
Con Berlusconi avvenne il contrario. Le risorse diminuirono, quelle nazionali e perfino quelle europee (nel 2008-2009, circa 16,5 miliardi di euro di fondi europei destinati al Mezzogiorno furono destinati a tutt’altre finalità, perlopiù dirottati sul Centro Nord: cfr. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, cit., p. 169), e non venne varata ovviamente nessuna riforma, tantomeno una che puntasse a ricentralizzare funzioni e competenze. Quanto alla classe dirigente, abbiamo già detto (ma per la verità si andava esaurendo, in quel periodo, anche molto del buono venuto dalla nuova classe dirigente di centrosinistra affermatasi negli anni Novanta, almeno nei comuni). Quanto poi alle infrastrutture di trasporto, mentre fra il 2005 e il 2012 si avviava e realizzava la moderna alta velocità, quasi tutta nel Centro Nord, per il Sud, a fronte di condizioni della tradizionale rete e servizio ferroviari già peggiori, si fece quasi solo un gran parlare, innanzitutto da Berlusconi, della costruzione di un ponte sullo stretto di Messina: ponte tuttora inesistente. Si cominciarono poi a realizzare le moderne infrastrutture telematiche, essenziali alla vita economica e anche civile, sociale e culturale, e anche questo avvenne inizialmente soprattutto nel Centro Nord.
A fronte di tutto ciò, c’è da stupirsi che nel decennio di egemonia berlusconiana, 2001-2011, il Pil pro-capite delle regioni del Sud, rispetto alla media italiana, sia rimasto fermo (68%). Pure, c’è da poco da gioire: quello è stato il periodo in cui il Pil pro-capite italiano è aumentato meno, in assoluto, di tutta l’età repubblicana, e in cui anche il Centro-Nord ha registrato la sua performance peggiore; il Sud, molto meno avanzato e quindi con un maggiore potenziale di crescita (non uno minore!), si è tenuto in linea con risultati tanto magri. In quegli anni si è accentuata anche la crisi demografica del Sud Italia, con emigrazione delle persone più preparate, con il tasso di fecondità che è sceso per la prima volta al di sotto di quello del Centro Nord, mentre la quota di popolazione diminuiva dal 35,5 al 34,4%.
Non è un caso che, in quella condizione così stagnante per il Mezzogiorno, ostentatamente ignorato dalla politica nazionale, cominciarono proprio allora ad avere successo interpretazioni, storicamente false, sull’arretratezza meridionale che potremmo definire di stampo «sudista»: interpretazioni cioè che davano la colpa della mancata convergenza a un presunto sfruttamento da parte del Nord e che assolvevano invece le inefficienti e corrotte classi dirigenti meridionali. A suo modo, un altro dei lasciti dell’era berlusconiana alla vita civile, sociale e culturale dell’Italia, benché su questo le sue responsabilità siano solo indirette.
L’ultimo aspetto è, probabilmente, il più noto. Il discredito gettato sulle istituzioni e sulla reputazione del Paese, prima dal suo conflitto di interessi e dalle ombre sulla sua carriera da imprenditore, poi anche dalle sue frequentazioni internazionali (l’ostentata amicizia con Putin anche dopo il suo discorso alla conferenza di Monaco che, nel febbraio 2007, inaugura la fase di sfida aperta della Russia all’Occidente); infine dai suoi comportamenti privati.
Specie per questi ultimi, e specie durante il suo quarto governo (2008-2011), Berlusconi ha finito per ridicolizzare l’immagine dell’Italia agli occhi del mondo e lo ha fatto per giunta in una congiuntura economica e finanziaria estremamente delicata – la crisi del 2008 e poi quella conseguente, interna all’Europa, dei debiti sovrani del 2010-2011. Una congiuntura in cui noi avremmo avuto bisogno, al contrario, di essere percepiti come affidabili e seri dalla comunità economica internazionale. Il conseguente ciclone finanziario che, nell’autunno del 2011, investì l’Italia sarà la causa principale della sua caduta.
 6. Il gran finale
6. Il gran finale
Anche se non più dominante, Berlusconi ha continuato a esercitare una grande influenza sulla politica italiana, grazie al bacino di voti (in declino ma consistente) che raccoglieva con Forza Italia e al suo potere mediatico ed economico. Il suo ultimo atto significativo per la storia del Paese è stato schierarsi con Meloni e Salvini nel favorire la fine del governo Draghi, nel luglio 2022, arrivando a spaccare su questo profondamente il suo stesso partito, con la fuoriuscita di alcuni degli esponenti più apprezzati.
Quel che restava di Forza Italia è stato portato da Berlusconi di nuovo nel centrodestra, questa volta però in un assetto in cui questa forza era nettamente minoritaria, rispetto alla somma delle due formazioni più estreme, FdI e Lega (entrambe a destra del Partito popolare europeo).
La premier da lui sostenuta, Giorgia Meloni, e che deve anche a queste decisioni di Berlusconi la sua vittoria (e che ha deciso di proclamare il lutto nazionale per la sua morte), si ispira apertamente al modello polacco: un Paese in cui l’estrema destra al governo, e sua alleata in Europa (il partito Diritto e giustizia), dal 2015 a oggi ha gravemente compromesso i diritti civili e anche lo stato di diritto (l’indipendenza della magistratura, la libertà di stampa, i diritti delle donne e delle persone Lgbt+).
Dal canto suo Berlusconi, quando era al governo, non ha mai promosso alcuna legge per i diritti civili, anzi ha spesso remato in direzione opposta (sul diritto a una morte dignitosa, sconcertante la sua uscita su Eluana Englaro «che potrebbe anche avere un figlio», nel febbraio 2009), e tantomeno ha difeso lo stato di diritto e le istituzioni democratiche, anzi ha cercato attivamente di minarle, piegandole ai suoi interessi (fra l’altro è stato il primo a cambiare la legge elettorale senza il consenso dell’opposizione, a suo favore, a pochi mesi dalle elezioni).
È arrivato al punto di ridicolizzare il Parlamento: esemplare il voto del 5 aprile 2011 in cui, per cercare di sottrarre alla procura di Milano la competenza di un’indagine su Berlusconi, la maggioranza dichiarò che Karima El Mahroug (una ragazza marocchina minorenne conosciuta con il nome d’arte di Ruby Rubacuori, arrestata per furto nel maggio 2010 e rilasciata dopo una telefonata di Berlusconi alla questura in cui il premier sostenne che era la nipote del presidente egiziano Mubarak) era effettivamente la nipote di Mubarak.
Le istituzioni però, anche grazie a una buona dose di fortuna, hanno complessivamente tenuto. Possiamo solo sperare che reggano anche in questa nuova fase, quella del governo più a destra che si sia mai visto in tutta l’Europa occidentale, finora, e che è stato il suo ultimo lascito all’Italia.
Fonte: Questo articolo fa parte dello speciale La morte di Berlusconi pubblicato dalla Rivista Il Mulino
 Emanuele Felice insegna Economia applicata nell’Università D’Annunzio di Pescara. Fra le sue opere più significative, (tutte pubblicate da Il Mulino): Perché il Sud è rimasto indietro (2013), Ascesa e declino. Storia economica d'Italia (2015), Storia economica della felicità (2017) e La conquista dei diritti. Un'idea della storia (2022).
Emanuele Felice insegna Economia applicata nell’Università D’Annunzio di Pescara. Fra le sue opere più significative, (tutte pubblicate da Il Mulino): Perché il Sud è rimasto indietro (2013), Ascesa e declino. Storia economica d'Italia (2015), Storia economica della felicità (2017) e La conquista dei diritti. Un'idea della storia (2022).





